Considerato il concept stringente di mettere in scena quella che è stata l’esperienza di un lungo reportage, diversi giorni passati con David Foster Wallace per conto della rivista Rolling Stone, The end of the tour poteva finire malissimo. Misurandosi nell’impresa inconsueta di adattare per lo schermo un articolo, per quanto lungo ed esaustivo, il film poteva cadere in diverse trappole ed è stupefacente invece quanto riesca ad evitarle. Questo gioiello di James Ponsoldt non solo centra il suo obiettivo (raccontare la personalità, le idiosincrasie e i problemi di David Foster Wallace) ma riesce addirittura a restituire con un grado coinvolgente di dubbi e ambiguità il mondo in cui aveva scelto di vivere, lo statuto che desiderava per se stesso come scrittore e la maniera con la quale si imponeva di abitare il sistema letterario.
Estraneo per carattere e personalità al genere del biopic (anche la provenienza, cioè un articolo e non una biografia agiografica aiuta), The end of the tour ha nel minimalismo espressivo la sua carta vincente. Quel paradigma molto abusato per il proprio genere che vuole la scrittura subordinata all’interpretazione (la prima molto usuale e ripetitiva, la seconda sempre enfatizzata e sottolineata con il mimetismo), qui non si smentisce ma anzi viene innalzata da uno svolgimento intelligente e dalla maniera sottile e moderata con la quale hanno lavorato sia Jesse Eisenberg che Jason Segel. Il David Foster Wallace che viene tormentato, intervistato, amato e odiato nel film è una figura tanto fuori dai canoni quanto in fondo piccola e tenera; tanto aderente allo stereotipo dello scrittore matto e appartenente ad un proprio mondo, quanto un uomo di provincia dalle debolezze molto comuni. In questo senso la scena finale, per quanto annunciata, suona realmente sorprendente.
In questo film che ha il suo punto debole nella figura di Lipsky, l’intervistatore (inutilmente protagonista, grossolanamente tratteggiato), c’è una qualità simbiotica tra l’epoca e la persona raccontata che avvince. Come se in ogni scena un segreto nascosto spingesse lo spettatore a voler vedere la successiva, la fotografia slavata, tarata sui toni chiari e focalizzata a restituire lo squallore degli ambienti, il montaggio invisibile e la struttura narrativa ugualmente classica, sono manipolati con tutta l’abilità necessaria a far sembrare che non ci sia manipolazione alcuna, come se la storia si raccontasse da sè.
Così la qualità migliore che un film possa esibire, una narrazione scorrevole e inarrestabile, qui diventa anche quell’elemento che rompe la banalità e raggiunge l’obiettivo che quasi tutti i biopic mancano: mettere in scena non tanto l’uomo quanto il suo lavoro.

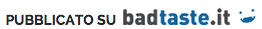
Nessun commento:
Posta un commento