I fratelli Affleck stanno allineando sempre di più i loro stili di recitazione.
Quando non alle dipendenze di grandissime major in progetti milionari (ad esempio nel ruolo di Batman) Ben Affleck sceglie sempre di più un’interpretazione fatta in sottrazione. Lo aveva fatto per sé in Argo o The Town e lo fa di nuovo qui, in un ruolo che presta il fianco all’espressione vuota ma che sembra che l’attore ceselli crogiolandosi nell’arte del minimalismo recitativo. Un po’ come il fratello Casey, che da sempre cerca di fare il meno possibile per raggiungere i suoi obiettivi in ogni scena, prediligendo personaggi silenziosi e introversi.
In The Accountant il contabile protagonista è affetto da una forma di autismo funzionale, vale a dire che con molto rigore e disciplina può vivere una vita normale. Pieno di fisime e manie, è molto più abile della media in tutto ciò che richiede concentrazione e quindi nel suo lavoro.
Invece che prendere la piega di Rain Man però questa storia di due fratelli e di un padre invadente che li ha educati in maniera molto dura, prende la strada del cinema criminale, dell’azione e della violenza. Perché assieme alla matematica il contabile pratica le arti marziali con la stessa perizia e minuzia, ha un addestramento militare che lo rende letale. Caratteristiche indispensabili se vuoi fare il freelance per la malavita.
Non ci sono dubbi che il più grande degli Affleck fosse la scelta di casting giusta, e che Anna Kendrick sia un contraltare perfetto, nei panni della contabile minuta e sempliciotta che scopre un problema di contabilità in una grossa compagnia, la quale poi assume il protagonista per “verificare e riparare”. I dubbi semmai sono sulla forza che questa volta violenza e sentimento prendono in un film di Gavin O’Connor.
Chiunque abbia visto Warrior, il film del 2011 con cui questo regista ha cambiato la propria carriera, ha capito che la maniera in cui è in grado di far dialogare la parte animalesca dell’uomo con quella molle, è unica. The Accountant non è impermeabile a questo, anche qui il dialogo è solo una delle forme di comunicazione, perché un’altra viene dal menare, dall’essere violenti, dalla rabbia che diventa lentamente sentimento, dagli atteggiamenti in lotta che parlano di cosa avvenga nelle teste delle persone. Ma è una pallida imitazione.
Pure spunti interessanti come la maniera in cui il protagonista condiziona se stesso, “allenando” la propria percezione, bombardandosi scientificamente di stimoli non ha la forza della mente che vince sul corpo, di una volontà incrollabile che piega i problemi della carne.
Addirittura nel finale, cercando di andare a parare proprio lì dove trionfava Warrior, Gavin O’Connor e Bill Dubuque (già sceneggiatore di The Judge) applicano la struttura di un film ad un altro per salvarlo. E come tutte le pezze anche questa non regge fino in fondo.
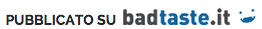
Nessun commento:
Posta un commento