Film come Il Diritto di Contare nascono a tesi, con una missione davanti a sè, nel caso specifico: fare luce sul ruolo di alcune donne afroamericane nella più grande impresa della NASA, la corsa allo spazio. Rientra nelle sue ragioni d’essere il fatto di avere una prospettiva ben chiara e un atteggiamento parziale. Nonostante abbia un piede ben piantato nella realtà dei fatti (personaggi reali, storie vere, contesti plausibili), lo stesso l’avere una missione porta questo genere di film a travalicare quasi subito il reame del concreto per accedere a quello più fantasioso. Sì svolgono cioè in un mondo che non è esattamente il nostro, ma una sua versione più semplice e chiara, dove tutto è netto e semplice da identificare. Sono a tutti gli effetti versioni favolistiche degli eventi reali.
Insomma quello del dramma di rivendicazione storica è l’unico genere a cui, per costituzione, è consentito di affermare come se ci credesse davvero che la storia si è svolta come la mitologia, che ne ha avuto gli stessi caratteri di manicheismo e la medesima retorica.
Non sorprende quindi che la storia di queste donne, inizialmente tenute ai margini (per sesso e colore della pelle) in un ambiente di soli uomini bianchi e poi con fatica riconosciute per l’importanza e le doti che potevano dimostrare, sia raccontata con il massimo dell’epica avventurosa, non lesinando nemmeno un dettaglio della retorica filmica. Le protagoniste sono ritenute poco più di casalinghe, non capaci di calcoli complessi, gli uomini intorno a loro si stupiscono di qualsiasi cosa, i dettagli di vessazione peggiori (andare al bagno in un altro stabile) vengono rivelati al momento giusto e portano alla più simbolica delle conseguenze (l’abbattimento del cartello “White only” con una mazza), nulla si svolge come nella vita reale e tutto è esagerato perché Il Diritto di Contare non racconta davvero come Dorothy Vaughan, Mary Jackson e Katherine G. Jackson abbiano fatto carriera in un mondo di uomini bianchi, ma che cosa sentimentalmente questo abbia significato. Non è la storia dei fatti, è la storia delle emozioni che ad essi erano legate, per questo si può permettere di travisare il travisabile per strappare una lacrima in più.
Non ha allora senso parlare di implausibilità per un film nasce per non averne. In questo senso Il Diritto di Contare è allora impeccabile e lavora bene proprio su quelle componenti che non deve fallire: struttura e cast. Più che la sceneggiatura infatti (non eccezionale) è il ritmo e la scansione del film, la maniera in cui gli eventi si succedono creando il climax corretto per le scene madri, a fare la differenza. In questo Theodore Melfi dimostra di avere il polso giusto per non strafare né sottoutilizzare il materiale a disposizione.
Dall’altro lato esiste anche quel margine giusto per ogni attore per calzare il proprio ruolo con la teatralità necessaria. Da Kevin Costner e la sua integrità tutta d’un pezzo, all’odiosità di Jim Parsons fino al gelido approccio di Kirsten Dunst, come nelle favole sono i cattivi a fare la partita, tutti interpretati con gusto e capacità di dare una ventata personale ad un ruolo molto noto, finalizzato unicamente all’esaltazione delle protagoniste.
Film come Il Diritto di Contare sono forse l’unica categoria che invece che portare avanti un discorso ne ratifica la sua vittoria. Non si produce un film così, non si scrive e poi racconta una storia simile, con questo tono e questa sicurezza nell’assegnare colpe e meriti, se i fatti e i problemi messi sul piatto non sono già ampiamente digeriti, discussi, accettati e inglobati dalla società che poi riceverà il film. Questo non è il cinema di rottura, è semmai quello che presenta allo spettatore l’opinione che questi già ha in una forma affascinante, per confermare il suo pensiero tramutandolo in grande epica.

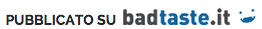
Nessun commento:
Posta un commento