C’è sempre stata una regola non scritta ad Hollywood: il passato si rievoca per esaltare lo spirito americano, anche se per antitesi. Si racconta un evento glorioso o se si deve raccontare qualcosa di marcio, di sbagliato e di brutto, lo si deve fare battendosi il petto contriti e affiancando un personaggio puro in cui risiede la speranza di un domani migliore, qualcuno che riconosce il marcio e quel sistema lo combatte. Nel marcio nazionale insomma non c’è esaltazione né divertimento (l’esatto contrario del cinema italiano).
Solo negli ultimi anni è nato un genere completamente diverso, uno che si esalta nella demenziale e incredibile assurdità della realtà e del crimine che paga. Storie vere, raccontate per esaltarne il grottesco, con i costumi, la recitazione, i colori e il montaggio, un trionfo di falsità per mettere in scena tutto quello che va male o è andato male come se appartenesse ad un altro mondo, quello del cinema.
Tra i primi film a fondare questo genere è stato Pain and Gain ma l’esempio aureo è e rimane The Wolf Of Wall Street (ha creato quel ritmo, quell’estetica e quel senso di profonda esaltazione insita nell’esagerazione, nell’andare sovraeccitati dal successo), quello che Trafficanti e La Grande Scommessa hanno seguito e ora Barry Seal cavalca.
Sono gli anni ‘80 del sogno americano portato alle conseguenze più paradossali, del capitalismo esagerato e libero, quelli in cui Barry Seal decide di smettere di fare il pilota di aerei e cominciare a lavorare per il cartello della droga colombiano. Le sue doti di grandissimo aviatore sono indispensabili per inondare l’America di droga, senza essere beccato, in cambio ci sono moltissimi soldi e uno stile di vita pazzesco, ma tutto ha un prezzo. Braccato dagli aerei militari, accompagnati da altri aviatori che si addormentano alla cloche, intento ad amplessi ad alta quota mentre sta pilotando (la scena che meglio mostra lo spettro di sensazioni che il film cerca di coprire, dal grottesco all'eccitante) e creatore di piani assurdi per le consegne, Barry Seal non solo è un criminale ma se la gode con il miglior sorriso di Tom Cruise.
Doug Liman si diverte tantissimo e fa divertire il pubblico nel mettere in scena gli anni ‘80 “eccitati” da droga, donne e denaro, quelli in cui tutto è possibile in barba alla legge, quelli in cui l’edonismo che oggi riconosciamo così bene si traduce anche in una ricerca senza regole del lusso. Prende una storia molto semplice e lineare, quasi prevedibile, e la ingarbuglia con il montaggio per renderla originale e sorprendente. Fa di tutto per creare una grande avventura umana, e a tratti ci riesce pure. Di certo diverte.
Negli anni in cui la tv ha liberato il concetto di antieroi il cinema sembra incorporarlo anche così. E che sia Tom Cruise a farlo è ancora più clamoroso. Diventato cattivo solo in pochissimi casi (ed eccezionali, come con Michael Mann in Collateral), Cruise qui per la prima volta è un avido e meschino, che (grazie al genere cui appartiene Barry Seal) non è costretto a rinunciare a piacere al pubblico, ad essere desiderabile. Anzi, in certi punti sembra che il suo star power incontrastato influisca sulla storia, come se Barry Seal (personaggio) potesse permettersi addirittura di tenere testa a Pablo Escobar perché c’è Tom Cruise ad interpretarlo.
È un supereroe che acquista i poteri quando accede all’empireo di chi è impermeabile alle regole smettendo di essere “vivere il resto della mia vita come uno stronzo qualunque” come lamenta Ray Liotta nel finale di Quei Bravi Ragazzi, il vero antesignano di quest’idea.
Insomma la storia vera messa in scena senza un briciolo di nostalgia, come anzi era una volta, ma con le qualità moderne. Non guardata all’indietro, indugiando nei toni dolceamari, su musica e costumi d’epoca, ma guardata come fosse la contemporaneità, senza rimpiangerla, giudicandola aspramente tramite il grottesco.
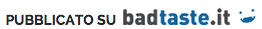
Nessun commento:
Posta un commento