CONCORSO
MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA
Musiche, voce fuori campo e architettura fosca e gotica da Tim Burton, più una protagonista muta e dai grandi occhi ingenui, fotografata con toni saturi su color correction da Jean-Pierre Jeunet. Nei primissimi minuti di The Shape Of Water solo un dettaglio rivela che stiamo guardando un film di Guillermo Del Toro: le sue onnipresenti maioliche bianche spaccate, il segno più evidente del gusto novecentesco di questo autore.
Comincia quindi all’insegna di un altro cinema e di mille ispirazioni uno dei film più in forma di un regista il cui ritorno era atteso da troppo tempo, uno che non era mai sceso così a fondo nel terreno del sentimentale, non aveva mai dimostrato di conoscere così bene i meccanismi dell’amore cinematografico.
Per compiere questa magnifica dimostrazione ha attinto a tutta la sua conoscenza e a tutto il cinema del passato (oltre al suo). Questa volta la creatura mostruosa che affianca la protagonista somiglia al Mostro della Laguna Nera, si innamora come King Kong, cura ed è braccato e poi nascosto come E.T. ed è rigettato da tutti nonostante il buon cuore come Frankenstein. Ma non solo. Per arrivare a quello zenith sublime di dolce commozione, in cui basta un gesto per spezzare il cuore, The Shape Of Water, come in un rito magico, evoca il noir dei neon e delle notti piovose, il musical guardato in tv e poi sognato, e uno score (di Alexander Desplat) così filologicamente sentimentale e melò, che oggi si pensava solo Todd Haynes potesse permettersi di usare.
Tutto per dar vita alla storia di un personaggio marginale, una donna delle pulizia muta e sola, interpretata da Sally Hawkins (come sempre fantastica, perché non ha la considerazione che merita??) e qui simile ad una Maribel Verdù prima maniera. Lei lavora in un bunker del governo dove arriva in gran segreto un mostro. Tutti lo maltrattano e lo vogliono sezionare, lei di nascosto ci comunica senza parole.
Del Toro continua a guardare a Tim Burton, ma stavolta è quello migliore (là dove Crimson Peak era il peggior Burton). La banda protagonista è un gruppo di persone “diverse”, considerate e marginali dalla società (gay, muti, intellettuali, donne, neri e donne nere), e di contro tutti quelli regolari e “normali” sono i peggiori, malvagi e gelidi, il simbolo stesso della mostruosità dell’omologazione. Però grazie al cielo al favolismo dark dall’autore di Edward Mani di Forbice Del Toro ci aggiunge il sesso, quello vero e non suggerito, quello disturbante, quello agognato, fondamentale e che cementa il sentimento.
E se stavolta si trova ai margini l’ambientazione storica, solitamente così importante nei suoi film (sarebbero gli anni ‘50 della guerra fredda) e solo perché schiacciata da un romanticismo devastante. A tenerla viva è solo il personaggio di Michael Shannon, frutto perfetto dell’American Dream, padre di due figli con moglie bionda e macchina nuova, ossessionato dalla decenza e dall’essere per bene, quella regolarità e quell’inquadramento nel nome del quale è commessa ogni atrocità. In altri film sarebbe stata una componente fondamentale e forse doveva esserlo anche qui, almeno a giudicare dal tempo dedicatogli, ma è marginalizzata dalla maniera in cui Del Toro utilizza il passato del cinema per recuperare quel modo di mostrare e parlare di sentimenti che oggi sarebbe inaccettabile. Come già faceva La La Land, in un genere demodè (il monster movie), questo film trova la nostalgia dei sogni passati, lavora su un immaginario che percepiamo come lontano e da cui ci lasciamo travolgere oltre ogni resistenza, fluttuando come nel momento migliore di tutto il film, in una massa d’acqua al riparo da tutto assieme ad un amore impossibile e bellissimo, così a lungo atteso.
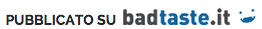
Nessun commento:
Posta un commento