Nonostante cerchi di mascherarlo nel cuore di The Greatest Showman c’è un musical di impianto molto vetusto. Quella di P. T. Barnum e della sua grande impresa, creare da zero uno spettacolo per cui valesse la pena pagare, il circo moderno fatto di animali, atleti e soprattutto “freak”, è in realtà la storia più che classica per i musical della seconda metà del novecento, quella di una compagnia che cerca di mettere in piedi uno spettacolo, con l’impresario nel ruolo protagonista, la trapezista in quello della bella ballerina (Zendaya) e i suddetti freak nelle parti comprimarie.
Nello specifico poi la direzione da prendere è chiara e semplice: Barnum ha salvato i freak da quel nome lì, dalla condizione di reietti, li ha radunati e gli ha dato lavoro, scopo e fierezza del proprio corpo. Loro nel complesso e Zendaya (sì, è considerata freak) in particolare, sono i grandi comprimari, hanno numeri musicali e costituiscono una specie di coro capitanato dalla donna barbuta, che soffre, spera e viene odiata dal pubblico. Il film però non gli dai mai il beneficio di una vera personalità. Sono una massa indistinta di cui sappiamo di dover avere pena, ma che non conosciamo mai. Dall’altro lato i personaggi veramente protagonisti sono quelli che nessuno metterebbe mai ai margini ma che il film tenta in ogni modo di convincerci che in realtà ci stessero, per la sola utilità di creare un parallelo.
Se narrativamente The Greatest Showman è abbastanza approssimativo, visivamente è evidente Michael Gracey abbia nel mirino Baz Luhrmann e quell’idea caotica, kitsch, colorata e molto pop di musical. Ma gli esiti sono così poveri e derivativi che si fa fatica a credere seriamente al modello. Semmai il film è più vicino a Chicago e quell’estetica ricca di sfarzo e povera di idee, in cui la coreografia dei balli è sufficientemente sofisticata ed elaborata ma mai nel comparto del fisico e del ballo vero. Tutto avviene infatti intorno ai personaggi che di fatto non ballano ma si muovono a tempo. Se un approccio simile è perfetto per La La Land (che mai punta sulla sofisticazione della messa in scena ma più sulla recitazione), è perdente in un film che si prefigge di mettere in scena un grande spettacolo.
Grande, questo spettacolo, lo è solo negli accorgimenti tecnici, ma questi non dialogano mai con il resto di quel che vediamo (le parti musicali non sono fatte per portare avanti la trama, né aggiungono peso ai personaggi). Una lunga serie di piccoli assoli, tecnicamente impeccabili eppure privi di personalità.
Inoltre più il film va avanti e più si ha l’impressione che invece che utilizzare musica e danza per esaltare quel che accade, queste siano usate per mettere delle pezze, tappare falle di storia e vivacizzare momenti morti. Il risultato è che The Greatest Showman non fa altro che enfatizzare i suoi molti problemi, il primo dei quali è una sbrigatività inspiegabile. Non ci vorrà molto infatti per P. T. Barnum per passare dall’insuccesso al successo, di fatto svilendo lo sforzo che dovrebbe dare un senso alla vittoria. Non ci vorrà molto nemmeno perché un personaggio cambi idea o perché un altro si convinca a fare quel che non voleva fare. Tutto accade con una rapida semplicità che è l’esatto contrario di quello di cui il film vuole convincerci, cioè che ci siano grandi sfide intellettuali in ballo, che ci sia un grande lavoro, una grande sofferenza e quindi una grande ricompensa.
Certo nei musical è sempre così, tutto è grande, grandioso e gigantesco, perché celebrano la vita alle massime potenzialità, il migliore dei mondi che non esiste e in cui si canta come si respira. Ma se tutta questa grandezza rimane più negli intenti e nelle coreografie, che nel senso della storia, è difficile riuscire a convincere.
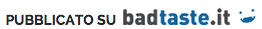
Nessun commento:
Posta un commento