Possedere uno stile molto riconoscibile porta inevitabilmente a ripetersi, ad indugiare su ciò che già piace al pubblico e in cui questo riconosce facilmente il proprio piacere. Wes Anderson è oggi il cineasta in assoluto più riconoscibile di tutti, capace di lasciare la sua impronta su ogni elemento della messa in scena, eppure non si ripete. Realizza film superficialmente simili tra loro ma sempre diversi, perché invece che sedersi sul proprio stile lo ha continuamente evoluto e reso più complesso. Di film in film ha declinato il suo gusto in diverse intuizioni formali, invece di proporre sempre le stesse, per raccontare persone assurde ed eccezionali mosse da sentimenti banali come quelli dei bambini.
Già Fantastic Mr. Fox aveva dimostrato come l’animazione fosse la forma di produzione che meglio calzi l’esigenza di Wes Anderson di controllare ogni dettaglio per raggiungere armonie impossibili ad altri (tanto che pure i suoi film dal vero somigliano effettivamente a cartoni animati), ora L’Isola Dei Cani è una conferma che proprio la stop motion e la sua particolare maniera di essere ferma e rigida è il campo in cui si esprime meglio. Chi ricorda il momento più bello di Le Avventure Acquatiche di Steve Zissou (quando Bill Murray sott’acqua chiama per la prima volta suo figlio come tale) sa che la commozione forte lì è data dal fatto che Owen Wilson non reagisca come ci aspetteremmo ma rimanga fermo, innaturalmente fisso.
In questo film su un futuro in cui una prefettura del Giappone segretamente fedele ai gatti prima ammala i cani per renderli invisi alla popolazione e poi li esilia tutti su un’isola di rifiuti, in cui i protagonisti che contano, quelli che parlano la nostra lingua, sono tutti cani (gli altri parlano giapponese e solo occasionalmente sono tradotti), Anderson utilizza molto la possibilità di tenere fermi i personaggi in modo che questo abbia un significato (non muoversi quando ci aspettiamo che lo facciano, creando la tensione di una mancata risposta o reazione emotiva) e di farli recitare come un umano non potrebbe.
E pare una liberazione. Wes Anderson adora affidare nei suoi film tutti i ruoli, anche i più piccoli, a delle star e qui la lista dei doppiatori è lunghissima (va da Bryan Cranston a Jeff Goldblum a Scarlett Johansson passando per piccoli ruoli di Bill Murray, Harvey Keitel, Frances McDormand, Greta Gerwig, Edward Norton e Liev Schreiber), eppure sembra che proprio non avere attori ma pupazzi ne esalti il controllo. Sembra che finalmente possa lavorare come vuole anche nella recitazione, alle volte riuscendo a cambiare le sorti di tutto un dialogo a seconda di quanto un personaggio rimanga fermo con il corpo alzando solo di pochissimo un sopracciglio.
L’Isola Dei Cani è anche il film che più cita l’umorismo classico dei corti animati per la tv Warner o Disney e in questo molto dell’umorismo arriva dall’attribuzione a dei cani delle caratteristiche dei personaggi andersoniani, come la compostezza che non è mai rigidezza morale (l’abbinamento più banale del cinema: chi è flemmatico è anche schematico) o la sofisticazione dei gusti e la ricercatezza delle opinioni. Eppure c’è in questa storia di ribellione, come in fondo sono quasi tutte le sue, un tema sottile e penetrante: l’idea che tutti si battano per controllare l’istinto tramite la ragione e il dilemma di qualcuno (il vero protagonista che emerge come tale solo dopo un po’) che nel suo passato non ci sia riuscito nonostante sarebbe normale per un cane, rimanendo ossessionato dal non riuscire a spiegarsene il perché. Cioè l’impossibilità di essere composti, razionali e andersoniani come si vorrebbe.
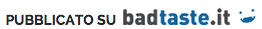
Nessun commento:
Posta un commento