Film come Zeta il cinema italiano sembra non conoscerne. Lungometraggi in cui si lavora sulla musica intendendola come uno sport, cioè come il frutto di un allenamento, finalizzata ad un trionfo materiale (vincere un contest, una gara o una rap battle) e intesa non tanto come arte ma come industria nella quale inserirsi, noi non ne facciamo. Nel nostro paese il cinema musicale è diverso, è una storia d’amore con il benefit di molte canzoni o una storia d’altro genere che ha al centro un musicista. Zeta invece guarda a modelli hollywoodiani e scambia così le forze in campo. Non un film di genere con canzoni, ma un film sulla musica che incorpori anche il genere.
Tre amici cercano di farsi strada nel mondo del rap ma solo uno viene notato da un rapper e produttore famoso e rispettato. Gli viene imposto di mollarli e dedicarsi ad una carriera solista, conosce così un fugace successo, rovina tutto e finisce per passare di cattiva amicizia in cattiva amicizia, fino a capire che alla fine di tutto nulla di quel ha ottenuto conta se non rimane fedele a se stesso. Lo dimostrerà iscrivendosi ad una rap battle, ovviamente in freestyle, contro il consiglio di tutti. Non importerà vincere ma dimostrare a se stesso di valere qualcosa realmente.
Non c’è grande originalità nello scheletro e questa è la prima forza di Zeta, cioè centrare un genere per bene. La seconda è avere dalla sua tutto il mondo del rap italiano che conta da Fedez e J-Ax fino a Metal Carter passando per Rocco Hunt e Baby K (i nomi sono molti di più e tutti esposti in locandina), dando ad ognuno una particina e ricevendo da ognuno un credito in termini di credibilità.
Purtroppo non sempre il film di Cosimo Alemà si muove con la confidenza che ci si aspetterebbe, non sempre ha la naturalezza dei film di genere migliori. Specie nelle prime parti non sembra a suo agio, e questo anche quando è aiutato da Salvatore Esposito nel ruolo del grande rapper che produce il protagonista (il fisico e le movenze sono perfette, bastano da sole a dare credibilità, la voce purtroppo no, perché quando canta è doppiato e si sente). Anche i tre ragazzi protagonisti, quelli che sulla loro pelle subiscono il percorso di successo e che vivono l’esperienza di “diventare un rapper” (cosa richieda, cosa implichi, cosa costi), non hanno la personalità giusta per rimanere impressi. Infine anche il momento di successo “troppo commerciale” arriva ed è narrato con una frettolosità che non ne restituisce l’importanza o la plausibilità.
Eppure tutto quello che funziona meno viene annullato dal finale. Il momento del classico showdown, quando il protagonista al culmine della sua passione personale si gioca tutto su un ring metaforico (che poi è il palco), avendo tra il pubblico la parte sentimentale della sua vita a motivarlo, è come non se ne sono mai visti. Non solo centra quello che è lecito attendersi ma si permette il lusso di sperimentare, variare e inventare.
Invece che essere motivato nella sua impresa dalla tenacia e dai sentimenti migliori, il protagonista è motivato da una mestizia e una rabbia da esclusi che si accoppia benissimo con il genere musicale, con le linee di rap e con un atteggiamento che urla da ogni gesto mancanza di speranze nel domani. La ragazza che in fondo ama ed è nel pubblico lo guarda con una fissità disperata, senza alcuna partecipazione eppure stando lì per lui, questo dà a tutta la scena un mood irreale, crea un senso di emarginazione potente e quasi commovente.
In un’unica scena conclusiva Zeta riesce davvero a condensare non tanto una storia di rap ma lo spirito del rap, quello che lo differenzia dal resto dei generi, e una personalità inconfondibile che non appartiene tanto dei personaggi quanto all’anima del film.







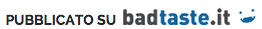


Nessun commento:
Posta un commento