Non ci sono dubbi che in Riccardo Va All’Inferno la visione sia quella buona. La maniera in cui Roberta Torre immagina un piccolo mondo urbanissimo (il quartiere Tiburtino Terzo di Roma) tra sotterranei analogici in cui si muovono esseri dalle sembianze inquietanti di Jean Pierre Jeunet, e una superficie per bene e grottescamente opulenta da Tim Burton, tutto reso tramite soluzioni visive anni ‘90 (come i colori fluo sparati o gli occhialetti e i vari dettagli di trucco e parrucco), è efficace. Un universo di cattivo gusto così coerente e ben pensato da dare l’impressione di essere il suo contrario. Addirittura questa visione si sposa pure bene con i presupposti della trama, cioè la cattiveria delle élite, l’infamia dei reietti e l’innocenza da corrompere.
Questo svolgimento da Tim Burton, asciugato dal romanticismo e dalla poesia, però sembra non essere mai supportato da un vero svolgimento. Ben presto si comincia ad avere l’impressione che Riccardo Va All’Inferno esista per raccontare il proprio delirio visivo e non una storia. Certo l’intreccio c’è (Riccardo è uscito di prigione e vuole riprendere il dominio del suo quartiere da una famiglia che gli ha fatto solo del male) ma il film ci punta poco, lavora il minimo sulle interazioni, sulle motivazioni, sulle svolte e sull’uso di questa dimensione visiva per definire, arricchire e servire la narrazione.
Nonostante le musiche di Mauro Pagani si accoppino molto bene con il look, la bava, i capelli sporchi e le divise militari, creando un’ambientazione fuori dal mondo che il film ha la grande idea invece di radicare tramite le già dette coordinate urbanistiche, lo stesso Riccardo Va All’Inferno sembra uno showcase di situazioni. È odioso da scrivere e così abusato da suonare puerile, ma il film sembra un videoclip, nel senso che relega la narrazione a poco più di un pretesto e affianca immagini che esistono ed hanno senso per il proprio look. Solo che i videoclip avevano fatto di questo un linguaggio, a volte narrativo, a volte no, ma sempre funzionale ad un rapporto dialettico con l’identità del performer. Qui non ci può essere niente di tutto ciò (anche se ci sarebbe potuto stare eh, si poteva lavorare sul protagonista Massimo Ranieri e la sua identità, ma non è la volontà del film) e ciò che rimane è per l’appunto una serie di spunti, ricordi con la calza, capelli, interni, mobili e trucchi tutti splendidi ma su una trama pretestuosa e quindi inevitabilmente noiosissima.






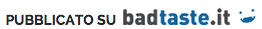

Nessun commento:
Posta un commento