Non ha cambiato praticamente nulla Paolo Genovese dalla serie tv che ha adattato in film, The Booth At The End. C’è un uomo in un diner che da noi è un bar che sembra un diner americano, che con un grosso librone assegna compiti più o meno abietti a persone che vengono da lui chiedendo di esaudire dei desideri (“Voglio essere più bella”, “Voglio che mio marito guarisca dall’Alzheimer”, “Voglio fare pace con mio figlio”) e tutto il cuore del racconto sono le maniere in cui questi malcapitati raccontano i progressi che stanno facendo nel portare a termine operazioni come costruire una bomba e far saltare in aria un locale, violentare una donna, farsi mettere incinta, rubare dei soldi…
Genovese sembra aver capito subito qual è il punto di questo spunto, il fatto cioè che in questo film esistano almeno altri 6 film di genere diverso che hanno luogo solo nella nostra testa tramite i racconti dei protagonisti. Senza mai uscire da quel bar sentiamo raccontare di come qualcuno abbia cercato senza successo di rapire una bambina, sentiamo di come qualcun’altra abbia cercato di farsi beccare con un’altra dalla di lui moglie o ancora dei tentativi di rapina. La recitazione sostituisce (per quelle storie) tutte le altre componenti della messa in scena e di conseguenza la regia deve essere tutta al suo servizio, invisibile e accattivante.
Ad avvincere, oltre ai singoli racconti, è sempre la curiosità che c’è dietro la natura stessa del film: siamo nel fantastico? Quest’uomo ha dei poteri? È solo una persona che lavora come uno psicologo? Quali regole vanno rispettate? Farà quel che dice?
In quest’ambiguità nella quale trionfa Valerio Mastandrea e la sua espressione impassibile che in realtà dice molto, si gioca la tenuta del film, la sua capacità di tenere attaccati e stimolare lo spettatore ad attendere il procedere delle storie. Ovviamente la fortuna di potersi permettere un cast numeroso di tutti volti noti aiuta ma a stupire non è quello quanto come Paolo Genovese, che era diventato famoso con commedie molto scialbe ed è esploso con la più seria di queste (Perfetti Sconosciuti), qui svolti nel drammatico puro e facendolo sembri aver trovato una strada che calza il suo mestiere molto meglio della precedente.
The Place non è un film eccezionale, ma proprio per questo motivo sembra che Genovese sia davvero a proprio agio, perché anche in un adattamento abbastanza pedissequo (sono uguali alla serie tv anche le singole storie e il personaggio della cameriera), si muove benissimo ed esalta a dovere un materiale che, è facile intuirlo, in altre mani poteva rendere molto meno. Proprio il suo stile estremamente tecnico e calligrafico lo aiuta, con un necessario moltiplicarsi di inquadrature differenti per mostrare sempre la stessa situazione senza uscire mai dai binari di una messa in scena invisibile e funzionale agli attori.
Alla fine nelle sue mani quella di The Booth At The End sembra una storia italiana, anche se non lo è. Sembra una storia di personaggi teatrali pirandelliani, una in cui ognuno mette in scena se stesso davanti ad un pubblico formato da una sola persona, in un film che insiste sottilmente su quelle debolezze umane che inducono le persone a chiedere un aiuto disperato.






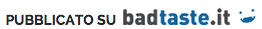

Nessun commento:
Posta un commento