Se qualcosa come un film Sundance egiziano d’autore può esistere questo è Yomeddine. Aperto da una scena che sembra lo stereotipo del cinema d’autore preso in giro da chi il cinema d’autore non lo guarda (nel silenzio di un’immensa discarica un lebbroso storpio ravana nell’immondizia con in sottofondo il ragliare solitario del mulo suo unico amico), Yomeddine replica tutti quegli espedienti con i quali quel cinema americano indie si è guadagnato i favori del pubblico arrufianandoselo nei modi più biechi.
Un uomo e un bambino, che non sono parenti ma sono uniti dall’essere emarginati e scacciati da tutti, viaggiano nell’Egitto peggiore in cerca delle proprie origini e delle proprie famiglie originarie non accorgendosi che stanno formando loro due un nuovo nucleo familiare non convenzionale ma vitale. Sono poveri ma di gran cuore (ballano e hanno solo sentimenti purissimi!), sono marginali e disprezzati con un buon grado di sofferenza (“Sono un essere umano anche io!” griderà il lebbroso scacciato da tutti al culmine del miserabilismo del film), ma A. B. Shawky ha per loro solo carezze sulla testa bonarie.
I due sono anche adorabilmente ignoranti e fuori da tutto, trovano vecchie riviste americane e pensano che Warren Beatty sia qualcuno di importante, sbagliano pure le parole arabe più complesse scambiando le sillabe come bambini piccoli. Uno dei due infine suscita lo stupore di tutti quando si presenta con il nome con cui lo chiamano tutti: Obama.
Infelici ma ironicamente strambi, ridiamo di loro con l’illusione che anche loro riderebbero di se stessi se potessero capire, li guardiamo con un sorriso simile ad una paresi che nasconde una lagrima, come fossimo dei genitori inteneriti. O almeno così desidera il film.
Ovviamente nel loro viaggio denso di maltrattamenti (mai realmente violenti, per carità, è pur sempre una favola) troveranno aiuto vero solo dai propri pari, in un “momento freaks” in cui entreranno in contatto con altri storpi o mutilati dai quali saranno finalmente accettati.
A tutto ciò non mancano i sogni del più protagonista dei due, lo storpio sfigurato in volto dalla lebbra avuta in gioventù, che rivive il suo passato o anche gli eventi della giornata in incubi lievi che melodrammatizzano ancora di più la sua vita o che, al culmine dei tentativi di strappar lacrime lo fa specchiare e vedere con un volto e un corpo normali, come non avesse mai avuto la lebbra.
Mai in Yomeddine c’è un momento sincero in cui ai due derelitti protagonisti sia riservata un po’ di dignità che non venga come una concessione paternalista, mai al contrario c’è un momento di vera e autentica durezza, tutto naviga nel mezzo, attutito, usando la loro condizione per scatenare tenerezza. Mai insomma in questa favoletta che vorrebbe far della poesia ma non ne ha la capacità, incastrata com’è nell’autocompiacimento del melodramma, i due protagonisti sono guardati con sincerità ma sempre con l’intento di farli piacere al pubblico.






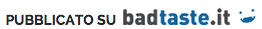


Nessun commento:
Posta un commento