Non è chiaro chi sia il pubblico di un film come The Women Who Left, almeno al di fuori del circuito dei festival o dei grandissimi appassionati, eppure forse non importa. Un film così, in cui l’intreccio suona come un thriller ma la messa in scena come semidocumentaristica (e non è nessuno dei due), forse va fatto a prescindere, per un pubblico che se oggi non c’è ci sarà domani. Perché c’è un indubbio fascino in queste lunghe inquadrature nelle quali Lav Diaz fa accadere l’indispensabile con il massimo dell’artificio in un mondo che è il massimo del reale. Per quanto trasfigurata in inquadrature che paiono fotografie patinate o dipinti, la realtà di The Women Who Left è tangibile, forse tanto più tangibile quanto più è puramente finzionale, messa in scena e cinematografica.
Una donna esce di prigione dopo anni di reclusione perché è stata acclarata la sua innocenza, torna nel suo paesino, là dove tutto è accaduto e fa una doppia vita, di giorno e di notte. L’idea è indagare sul piccolo boss locale, quello che la incastrò, e farlo fuori. In questa doppia vita incontra varia umanità in una specie di baraccopoli ai confini di tutto, un gobbo che vende uova la notte, un travestito che si prostituisce, alcuni negozianti, una famiglia assillata da una cicciona.
Lav Diaz parla una lingua tutta sua che trascende i confini nazionali (il suo non è “cinema filippino”) e gioca nel campo dei più grandi, nell’arena in cui si è battuto per anni Tsai Ming Liang, quella dei film frutto di un pugno di lunghissime inquadrature concepite con la massima sapienza, cinema che confida nella composizione e punta tutto sul visivo. In The Women Who Left le scene sono pianisequenza con videocamera immobile, ma ogni volta il punto scelto ha del clamoroso, dell’impressionante.
Non è solo il lavoro sulla profondità di campo (fantastico) o sulla composizione (gli attori non girano liberamente, sono piazzati per bilanciare tutta la scena) ad impressionare ma quella maniera misteriosa che ha ogni tavola di includere lo spettatore, di avvicinarlo e avvincerlo anche nei momenti in cui la trama non va da nessuna parte. Ogni scena di Lav Diaz è un piccolo film a sé di accattivante capacità di linguaggio.
Se nel cinema duro fondato da Scorsese atti come una vendetta armata da parte di una persona che non è un criminale sono degli inferni di terrore, in quello di Lav Diaz paradossalmente non è l’apice di nulla. Non saranno l’ingresso di una pistola, una piccola rissa, un confronto verbale o l’incontro con il nemico a colpire. Sono semmai le lunghe notti a farlo!
Con un nero fantastico (buio, totale e senza appello) ogni notte di The Women Who Left ha il sapore delle nottate estive, ha un odore ben preciso, crea la sensazione dell’umido estivo e lo fa proprio con i suoi tempi. Benché lungo solo 4 ore (un cortometraggio per i tempi di Lav Diaz), quest’opera fa della propria durata la propria forza, avvince in un mondo in cui l’attesa è superiore al risultato, in cui sì comincia a respirare un’aria diversa dopo un po’ che ci si è immersi. Pensare che il tempo non abbia un ruolo nella maniera in cui guardiamo un’immagine è follia. Tenerla pochissima ha un senso, tenerla tantissimo anche, la maniera in cui ci colpisce cambia. E molto.
E davvero è incredibile quanto una messa in scena così artificiosa, calcolata, ben composta e quasi matematica nella sua perfezione stilistica, riesca a giungere ad un’impressione di realismo e presenza dello spettatore nella scena. L’esperienza è così coinvolgente che qualsiasi durata non è più un problema.






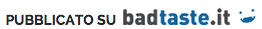

Nessun commento:
Posta un commento