C’è sempre nei film di Clint Eastwood almeno dagli anni ‘90 in poi (per tenerci stretti) un senso di compostezza e di economia di gesti che è una delle componenti più determinanti della meraviglia dei suoi film. Qui questa compostezza si manifesta con particolare evidenza nel protagonista, Sully, pilota dell’aereo che nel 2009 è dovuto atterrare nel fiume Hudson per evitare di schiantarsi su New York. C’è una ripetuta insistenza nel mostrare quanto quest’uomo agisca con rigore e determinazione in situazioni in cui tutti sembrano fare il contrario. Sia nella cabina dell’aereo (suo habitat naturale), sia negli uffici o sotto esame, che al telefono con la moglie, sempre lungo quei giorni frenetici ed emotivamente destabilizzanti (non è un’opinione, lo dice un medico che lui è emotivamente scosso), Sully fa pesare ogni gesto e ogni parola, Tom Hanks fa pesare ogni piccola variazione di un’espressione che è bravissimo a contenere e rilasciare mentre Eastwood con una forza calma che fa paura si comporta alla stessa maniera: dosa ogni dettaglio senza nessuna enfasi.
L’incidente che dura solo 208 secondi lo vediamo più volte, quasi sempre con un po’ di dettagli in più per non rendere noiosa la riproposizione di qualcosa di cui, già prima di vedere il film, conosciamo l’esito. Lo vediamo nei ricordi e nelle ricostruzioni ed è davvero forte come in un film in cui un professionista è messo sotto accusa per quel che ha fatto (o non fatto), ad ogni riproposizione degli eventi siamo portati naturalmente ad apprezzare sempre di più quel suo atteggiamento. Addirittura nell’ultima visione, la terza o quarta per noi, Eastwood ci porta per mano a concludere anche noi (che probabilmente già eravamo tutti persuasi della tesi finale) che si è trattato davvero di qualcosa di mirabile.
Perché il cinema è strano, ha come missione quella di distorcere la realtà evocare fantasmi e renderla paradigmatica di qualcos’altro, così l’ammaraggio di Sully non sembra gran cosa se proiettato sul medesimo schermo su cui Tom Cruise volava radente alla torre di controllo o Denzel Washington usciva illeso da un disastro ben più clamoroso in Flight. Eastwood allora il miracolo non lo mostra: lo costruisce. La medesima sequenza lungo tutto il film diventa epica, eccezionale, la medesima seria e misurata compostezza diventa un gesto potente, virile, duro, inflessibile. Quando il modo in cui si racconta una storia non può sfuggire all’evidenza di essere l’esposizione di un atteggiamento nei confronti della vita.
Peccato allora che il grande scontro che fa da sezione ritmica del film, quello dopo l’incidente tra Sully e la compagnia aerea che per non perdere soldi vuole dimostrare la negligenza del pilota (avrebbe potuto atterrare in un aeroporto vicino, sostengono), diventi una banale contrapposizione tra computer e uomo. L’analisi basata sui dati in loro possesso dice che il tempo di fare altro c’era, Sully e il suo istinto di vecchia volpe sanno che non è così. Le simulazioni fatte con altri piloti mostrano che effettivamente si poteva atterrare altrove, ma questi hanno la possibilità di provare più volte e sanno già che accadrà, Sully ha deciso tutto in un attimo. E alla fine quasi attesa arriva la frase: “La realtà non è un videogame!”, pietra tombale su una dicotomia che poco o nulla ha a che vedere con questa storia. Peccato perché distrae da uno scontro ben più pregnante e succoso presente nel film, quello tra individuo e corporation, tra un sistema (economico) che necessita di una vittima per preservare i guadagni e un altro sistema (mediatico) che necessita di mitologia, di un “eroe” da mostrare e di cui parlare, con il quale riempire gli occhi del pubblico per giorni.






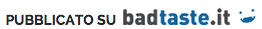


Nessun commento:
Posta un commento