“Auggie è il sole intorno a cui tutti noi orbitiamo”, con questa frase in Wonder viene spiegato come la famiglia Pullman viva in funzione del figlio più piccolo, August, nato con una malformazione al volto tale da richiedere diversi interventi di chirurgia per poter masticare, respirare e vedere. Il risultato è che Auggie ha un volto devastato. Ad 11 anni i genitori decidono di mandarlo per la prima volta alla scuola pubblica, smettendo di educarlo a casa. Wonder racconta questo: un anno nella vita di Auggie, l’anno in cui per la prima volta iniziò a vivere con gli altri, uscendo dalla bambagia confortante della famiglia e dovendosi confrontare con il pregiudizio del resto del mondo (per giunta quello già normalmente segregante della scuola media). E per farlo fa proprio orbitare tutti i personaggi intorno al protagonista, come tutta la famiglia Pullman orbita intorno ad Auggie. Finge di raccontare amici e parenti per portare avanti solo ed unicamente la storia di Auggie.
Wonder è un piccolo all star game della lacrima. C’è il bambino-attore di maggiore talento in circolazione (Jacob Tremblay), mascherato e truccato fino ad essere irriconoscibile, c’è un regista specializzato nella tenerezza e nelle storie di ragazzi (Stephen Chbosky di Noi Siamo Infinito) e uno sceneggiatore dalla mano pensate quando si tratta di far piangere con i sentimenti positivi (Steve Conrad, già responsabile di La Ricerca Della Felicità e I Sogni Segreti di Walter Mitty) che adatta un libro di successo il quale a sua volta racconta una storia vera.
Eppure Wonder rimane soprattutto un film di attori, nello specifico un film di Owen Wilson e Julia Roberts, i genitori di Auggie. I due giocano di sponda, lavorano ai fianchi lo spettatore e nel raccontare del figlio mettono in realtà in scena i loro di sentimenti. Il senso di esclusione e del desiderio di integrazione di Auggie infatti non espresso dalle sue peripezie ma dalle azioni e reazioni dei genitori rispetto ad esso. E per fortuna!
Nonostante una determinazione ferrea a tirare tutte le lacrime possibili dagli occhi di ogni spettatore puntando sull’esposizione dei sentimenti più cristallini che trionfano sui peggiori, sulla tenerezza, la pietà e un’irredimibile tendenza a trovare in ogni svolta un anfratto commovente, Wonder proprio lavorando di sponda sul resto del cast riesce a trasformare il processo di crescita e maturazione di un bambino in un lavoro di squadra. La storia di come Auggie abbia affrontato il mondo reale, e quindi le sue paure e i timori di essere giudicato dall’apparenza, è un trionfo umano e personale che Wonder racconta come uno sforzo collettivo, con tanto di ringraziamenti finali del bambino a tutti i personaggi che lo hanno aiutato. E così diventa subito più universale: un bambino come terminale dell’instancabile lavoro che avviene dietro le quinte della sua vita.
Le storia di formazione sono tradizionalmente individualiste, raccontano di come proprio per essere entrato in una foresta ed esserne uscito malconcio ma migliore solo con le mie forze io sia diventato qualcos’altro. Wonder supera quest’impostazione moltiplicando i calvari (oltre a quello del protagonista c’è quello della madre, del padre e della sorella, tutti orbitanti intorno a lui), e giunge al medesimo bieco obiettivo drammaturgico dei lacrima movie italiani degli anni ‘70 con Renato Cestiè, ma con un afflato e un senso della soddisfazione decisamente superiori.
In questo lavoro sembra trionfare silenziosamente Owen Wilson, attore completo e sempre più a suo agio nei piccoli film intimi. Sta ai margini ma non in vacanza, mai fuori post, fa l’uso migliore del poco minutaggio a sua disposizione, non ha diritto nemmeno ad una scena importante o cruciale, eppure è lui a creare il senso di famiglia, comunità e affetto che regge il film. Diventato noto per l’attitudine alla commedia, si rivela sempre più perfetto in storie personali da uomo ordinario, come questa o Io e Marley (dove grazie a lui un film “di cane” diventava anche in un film di uomini).






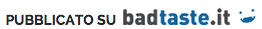


Nessun commento:
Posta un commento